
L’UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI NEL CONDOMINIO
L'UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI NEL CONDOMINIO
L’art. 1102 c.c., applicabile anche al condominio sebbene dettato in materia di comunione, consente al condominio di servirsi della cosa comune, “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Per quanto concerne la nozione di uso paritario della cosa comune, la Corte di Cassazione ha affermato che essa “non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri” (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808).
Quindi, a prescindere dalle quote di proprietà, ciascun condomino ha diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza; è possibile anche un uso più intenso della cosa da parte di un singolo, a condizione, tuttavia, che non venga pregiudicata la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 14107/2012), l’uso particolare e più intenso che il singolo condòmino intende trarre dal bene comune (ad esempio il muro perimetrale) deve essere compatibile con i diritti degli altri, in quanto i rapporti condominiali fondano sul principio di solidarietà, che impone un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Conseguentemente qualora il singolo condòmino volesse demolire una porzione di muro per ampliare o ricavare porte o finestre o per installare vetrine nel tratto corrispondente all’immobile di sua proprietà esclusiva, si verificherebbe solo un uso più intenso che non andrebbe ad impedire né a limitare il pari uso altrui.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha riconosciuto pienamente legittima l’apertura, sul muro condominiale di nuove porte e finestre, o l’ampliamento di quelle esistenti, trattandosi di interventi che di per sé non incidono nemmeno sulla destinazione della cosa comune (così, di recente, Cassazione sez. II, sentenza 03 gennaio 2014 n. 53¸ Cass. sez. II, sentenza 3 giugno 2015, n. 11445).
A tale ultimo proposito, la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha precisato che, poiché i muri perimetrali di un fabbricato condominiale adempiono alla funzione di recingere l’edificio, delimitandone il perimetro, il singolo condomino può legittimamente utilizzare il muro comune per aprire nuove porte e finestre (Cassazione, sentenza 5122/1990) ovvero per trasformarle in balconi o in vetrine di esposizione (Cassazione, sentenza 1390/1971) anche mediante l’abbattimento del corrispondente tratto del muro che delimita la proprietà del singolo immobile (Cassazione, sentenza 2703/1989), perché queste modifiche non incidono sulla destinazione del muro (Cassazione, sentenza 420200/2005).
Si evidenzia, infine, che la Cassazione, nella sopracitata sentenza 53/2014 ha affermato che per queste opere modificative, che non alterino la destinazione del muro, non impediscano l’altrui pari uso e/o non compromettano il decoro dello stabile – quest’ultimo da valutarsi in base alla linea estetica, avuto riguardo alla fisionomia della costruzione – non c’è alcuna necessità di ottenere l’approvazione assembleare, trattandosi di esercizio delle facoltà inerenti al diritto dominicale su parti comuni (si veda anche la sentenza di Cassazione 3508/98); e se il condòmino intendesse comunque sottoporle all’assemblea per ragioni di correttezza e civile convivenza, l’eventuale autorizzazione concessa rappresenterebbe un mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione, mentre l’eventuale delibera contraria non precluderebbe al richiedente la possibilità di attuare la modifica, indipendentemente dalla mancata impugnazione della stessa (si vedano anche le sentenze di Cassazione 1554/1997 e 3508/1999).
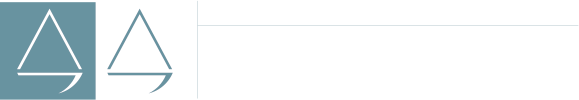
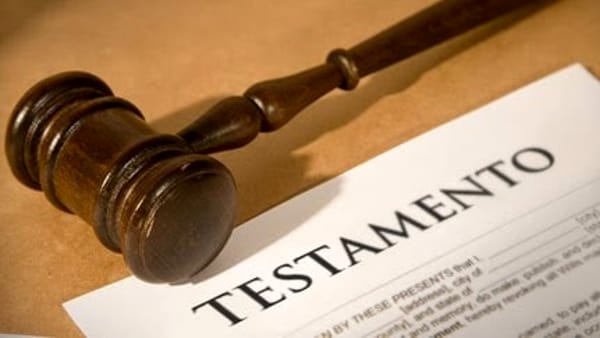



Commenti recenti